
di Claudio De Matté
Enron era uno dei casi più studiati e acclamati nelle business school statunitensi. Lo si presentava come esempio di strategia innovativa, precursore di un nuovo modello di impresa, reso possibile – se non obbligato – dalla spinta delle nuove tecnologie informatiche e telematiche (ITC) e dalla liberalizzazione dei mercati. Tale modello veniva contrapposto all’impresa tradizionale verticalizzata, che realizza e coordina al proprio interno rilevanti fasi della filiera produttiva con una struttura organizzativa gerarchica. In questa nuova versione, l’impresa realizza invece al proprio interno solo le funzioni e le fasi cruciali, in rapporto alle proprie competenze distintive, mentre si approvvigiona o commissiona all’esterno tutto il resto, coordinando l’insieme delle attività con le nuove tecnologie, da un lato, e con meccanismi negoziali di mercato, dall’altro, anziché con gli strumenti del coordinamento organizzativo.
Va detto, per chi non avesse seguito le vicende di questa impresa, che essa era in origine una tradizionalissima impresa statunitense di distribuzione di gas, carica di impianti (pipelines), fortemente integrata, poco internazionalizzata, ad alta intensità di capitale, con modello di gestione burocratico, com’erano tutte le imprese monopoliste prima della liberalizzazione. È cambiata radicalmente con l’apertura del mercato – prima del gas e poi elettrico – che ha non solo cavalcato, ma anche promosso con determinazione e (si è scoperto poi) con grande dispendio di fondi per attività di lobby sui politici americani. Sull’onda di questo processo, Enron ha progressivamente ceduto impianti, specie negli Stati Uniti, si è allontanata da quant’altro sapesse di attività manifatturiera, ha costruito piattaforme tecnologiche per mercati online, ha ritenuto che i margini non fossero nella produzione delle commodities, bensì nel comperarle e venderle con l’attività di trading. Messo a punto il modello lo ha applicato a vari altri settori, anch’essi soggetti a fenomeni di liberalizzazione, come l’energia elettrica e l’acqua.
Nel giro di qualche anno l’impresa era diventata leggera in termini di capitale investito, al centro di una fitta rete di rapporti contrattuali con fornitori e clienti, flessibile nei processi decisionali, con strutture organizzative essenziali, con margini sufficienti per generare ritorni interessanti, anche grazie al capitale relativamente modesto impiegato. La trasformazione di una utility tradizionale in un organismo così profondamente diverso non poteva passare inosservato. E infatti catturò l’attenzione non solo dei media, ma anche dell’accademia, che trovava in questo nuovo tipo di impresa la prova concreta di un’ipotesi che alcuni ricercatori avevano avanzato sull’evoluzione delle forme organizzative, basandosi su alcuni filoni di ricerca, quali quello dei costi di transazione, quello delle core competencies, quello delle imprese rete, per finire con quello dell’impresa virtuale. Queste ricerche indicavano che l’aumento delle informazioni disponibili e la riduzione dei costi per produrle e trasmetterle, assieme alla liberalizzazione dei mercati e alla conseguente maggiore concorrenza, avrebbero costretto le imprese a disaggregarsi in strutture leggere a rete, focalizzate nella produzione diretta solo sugli anelli della filiera (o della rete) sui quali esse godono di vantaggi competitivi, ricorrendo al mercato per l’approvvigionamento delle altre fasi o delle altre componenti sulle quale altri produttori sono più competitivi. Enron, grazie ai suoi primi risultati e all’aura di impresa nuova e vincente, è diventata anche l’oggetto del desiderio degli investitori. Oppure, secondo un altro punto di vista, le sue azioni sono diventate merce luccicante facilmente vendibile dagli intermediari finanziari ai risparmiatori. Quale titolo poteva risultare più appetibile di quello di una società che non solo è redditizia, ma è anche l’antesignana di un nuovo modello di impresa? Era il titolo ideale per vendere non solo il presente, ma anche il futuro.
Con queste premesse il titolo ha iniziato la sua cavalcata, che sembrava inarrestabile. Nessuno si era accorto che la vecchia azienda aveva cambiato non solo modello di gestione, ma anche natura. Da azienda manifatturiera era diventata soprattutto un intermediario. E pochi, anche fra gli stessi studiosi che avevano seguito la trasformazione, presentandola nelle aule come un esempio di un nuovo modo di fare impresa, si erano resi conto di quanto fossero cambiate anche le condizioni di vita e di successo di un’impresa siffatta: non avevano messo a fuoco quanto determinante fosse la fiducia dei mercati verso la medesima e quale peso decisivo potessero assumere le pratiche gestionali per preservare detta fiducia.
D’altro canto, nessuno si era accorto che il management della società, lungi dal seguire le pratiche di gestione che sarebbero state indispensabili, data la nuova e diversa natura, aveva imboccato una strada senza sbocco anche per un’impresa industriale: quella di imbrogliare i conti, dapprima per soffiare sul corso dei titoli, poi per non essere travolti dalla caduta. La storia successiva è nota: l’azienda è crollata, gli azionisti hanno perso tutti i loro risparmi; i dipendenti sono rimasti senza lavoro, ma anche senza le loro pensioni, dato che queste erano state prevalentemente investite in azioni della società; le banche hanno perso i loro crediti; il mercato azionario americano è stato scosso da una crisi di fiducia che richiederà tempo e interventi robusti per rientrare.
Molti studiosi e molti commentatori hanno messo in luce la gravità del fatto, rilevando le carenze di quasi tutti gli istituti simbolo di un sistema capitalistico: quello della revisione contabile che, in questo come in diversi altri casi negli ultimi anni, ha mostrato non solo una defaillance professionale, ma anche mancanza di etica (bruciando prove importanti, per nascondere i fatti); quello delle società di rating, che non hanno segnalato per tempo il degradarsi del merito di credito; quello degli analisti finanziari, che hanno continuato a emettere consigli di “buy” o perfino di “strong buy”, quando l’azienda era già entrata nella spirale viziosa; gli investitori istituzionali, che con tutta la loro expertise hanno continuato a comperare azioni fino all’ultimo; le grandi banche, che alla fine hanno cercato di sottrarsi ai loro rischi di credito con operazioni in conflitto di interessi rispetto alla loro posizione di creditori. Alcuni tra i commentatori non si sono limitati ad analizzare i fatti, ma hanno indicato ai pubblici poteri gli interventi da assumere per evitare gli effetti potenzialmente gravi di questa crisi sistemica, concentrandosi in particolare sulle modifiche da adottare a livello di norme contabili, di sistema di supervisione sulle società di auditing, di limitazione delle attività loro consentite, di cambiamenti da introdurre nei sistemi di governance. Poco è stato fatto, invece, per esaminare quanto accaduto dalla prospettiva del management: coloro che hanno la responsabilità di guidare le imprese che lezione possono trarre dal caso Enron e da altri che, pur non arrivando agli stessi estremi, sono emblematici di problemi nuovi emersi in questi ultimi anni?
Tre sono i problemi di management sollevati dall’esperienza Enron:
1. un problema tecnico-professionale;
2. un problema di etica comportamentale;
3. un problema di management in senso stretto.
Un problema tecnico-professionale: la rappresentazione della realtà aziendale
I primi commenti sul caso Enron si sono concentrati sui comportamenti scorretti del management. Ciò è comprensibile, dati i gravi danni causati a molti interlocutori. Ma il comportamento scorretto è solo una parte del problema.
Rientra in questo ambito la grande questione della rappresentazione della realtà aziendale: quella che nella vicenda Enron è stata definita come lo “scandalo contabile” o, con riferimento anche ad altri casi accaduti negli ultimi anni, la crisi di credibilità del sistema contabile. La prima grande lezione che si deve trarre da quanto accaduto è che il falso in bilancio, già grave di conseguenze per le società non quotate, diventa, per quelle quotate, una bomba a orologeria: una vera spada di Damocle che può provocare effetti devastanti sull’efficienza e la funzionalità dei mercati finanziari. I bilanci periodici sono messaggi che determinano acquisti o vendite, e quando essi siano fuorvianti causano allocazione inefficiente dei capitali e sperequazioni fra i risparmiatori.
Se è sbagliato sottovalutare il problema, è però altrettanto errato ridurlo a una mera ed esclusiva questione di normativa e di etica. Sottostanti vi sono quesiti difficili e nuovi che aprono ampi spazi di discrezionalità rispetto alla quale occorre un grande equilibrio di valutazione del management: quello che gli inglesi chiamano, anche nell’interpretazione legale, business judgement. Alcune di tali questioni non hanno precedenti, non sono corredate da un’esperienza consolidata, da norme o da quant’altro potrebbe fungere da guida. In altri casi ci sono le une e le altre, ma la loro applicazione comporta un delicato esercizio di interpretazione, perché gli elementi di cui tenere conto sono diversi e portano a conclusioni divergenti. Di fronte a questo spazio dilatato di discrezionalità, il management può porsi con intenti truffaldini – come è accaduto nel caso Enron – oppure con grande rigore morale. Ma anche in quest’ultimo caso si trova esposto a possibili errori che – ex post, nel caso che le vicende volgano diversamente da quanto previsto – possono gravarlo di responsabilità. Di fronte a questa complessità, il rigore normativo che non tenga conto della oggettiva natura del problema e della natura essenzialmente estimativa di certe poste contabili finisce con l’essere ingiustamente penalizzante nei confronti dei dirigenti che si assumono la responsabilità di fare il bilancio; per converso, il management che non tenga nel debito conto la delicatezza delle proprie valutazioni e le conseguenze che esse hanno nei confronti dei risparmiatori viene meno alle sue responsabilità professionali, prima ancora che etiche.
Il problema di fondo è che la rappresentazione contabile della realtà aziendale – sempre difficile, come tutte le misurazioni su fatti non meramente fisici – è ancora più difficile con l’avvento della nuova economia, caratterizzata dalla prevalenza dei servizi sui prodotti, delle attività intangibili su quelle tangibili, dall’articolazione delle imprese in gruppi, dalla disaggregazione delle imprese in imprese rete o perfino in quelle che vengono definite imprese virtuali (Enron insegna). In queste nuove condizioni, molti più termini dell’equazione contabile sono oggetto di rilevanti difficoltà di misurazione: i ricavi, o meglio il valore della produzione, con le relative poste connesse alla variazione dei magazzini, dei lavori in corso e delle capitalizzazioni; il valore delle partecipazioni; le imprese e quindi i valori da includere nel bilancio consolidato; l’ammortamento dei goodwill, ma anche di altri beni a valore altamente instabile; l’accantonamento dei fondi rischi (su crediti e altro), tenuto conto della forte instabilità del sistema e della crescita esponenziale del contenzioso; gli impegni relativi a transazioni su derivati. Non è questa la sede per la trattazione dettagliata di tutti i problemi che sorgono relativamente a queste singole poste. Ma un ragionamento su alcune di esse è utile per illustrare la natura della questione, la complessità del problema e l’atteggiamento e la professionalità che è necessario avere per affrontarlo.
Prendiamo il caso dei ricavi da fatturato. In un’economia industriale la determinazione di questa posta è relativamente (si fa per dire) semplice: sono i beni che sono stati spediti e fatturati, corretti per gli eventuali resi per difetti rispetto a quanto promesso. Eppure, anche in questo tipo di economia possono aprirsi varchi alla discrezione, com’è accaduto nel caso Freedomland, per la possibilità di registrare come ricavi anche vendite forzate ad agenti che non si sono ancora trasformate in vendite finali (sell-out).
Che cosa succede quando l’attività è un servizio, e soprattutto se questo è un servizio complesso la cui “consegna” non è un fatto che si apre e si chiude in un istante ma un rapporto prolungato, come accade in un progetto di costruzione di un sistema di software? In questo caso, la determinazione in un preciso istante di quanto della totalità del progetto e del suo prezzo è stato realizzato ed è fatturabile è di difficile valutazione perfino per gli addetti diretti, e a maggior ragione per chiunque sia collocato a livelli superiori. Questa difficoltà a dare una misurazione oggettiva si presta a un anticipo di fatturazione o ad un posticipo che per un’impresa la cui attività sia concentrata su questo campo può comportare scostamenti rilevanti fra un periodo e l’altro. In questo caso, ad arginare la possibilità di sopra- o sottofatturazione c’è il cliente, che solo in alcune circostanze può avere un interesse convergente con il venditore nello spostare nel tempo quello che per lui è un costo. Questo argine non c’è sul fronte della valutazione dei lavori in corso. La natura di certi servizi della nuova economia – e in particolare tutti i prodotti ad alto contenuto tecnico-scientifico – li rende di difficile valutazione anche per gli addetti diretti, i quali peraltro possono avere un incentivo (in presenza di bonus) ad amplificare il lavoro eseguito. Queste difficoltà di valutazione si intensificano quanto più brevi sono i tempi di chiusura dei bilanci, sicché si assiste a un oggettivo conflitto fra la volontà delle autorità di borsa a imporre un’informativa sempre più stretta (trimestrale, in certi casi) per migliorare l’efficienza dei mercati e la difficoltà oggettiva a sezionare con esattezza un flusso di ricavi che non è più costituito da una serie di transazioni discrete, ma da un flusso di servizi a decorso incerto. Una forte contabilità industriale che tenga traccia in tempo reale di questi avvenimenti e una stretta integrazione dei sistemi contabili sono l’unica strada percorribile per gestire il fenomeno con la maggiore precisione. Cisco sembra indicare la strada, essendo attualmente in grado di chiudere i sistemi contabili e comporre il bilancio con poche ore di preavviso. Rimangono, tuttavia, notevoli problemi di valutazione (per esempio sui lavori in corso) che né il management né gli organi di governo possono semplicemente delegare alla funzione contabilità.
Più delicata ancora è la questione delle capitalizzazioni, che corrispondono a lavori interni a produttività differita e protratta: in breve, lavori che si traducono non in fatturato, ma in investimenti per il futuro. In un’economia postindustriale queste poste possono assumere valori importanti. Si pensi a una società di genetica che può lavorare per anni senza fatturare alcunché, pur producendo valore reale perché sta incubando un nuovo prodotto. Si pensi a una società di software di prodotto – non un semplice system integrator – che dedica centinaia di persone a sviluppare un nuovo software. Cosa si deve fare al momento della formazione del bilancio? Considerare questi costi dedicati alla costruzione di un nuovo principio farmaceutico o a un nuovo software, oppure a una nuova applicazione che darà frutti in esercizi futuri, come un costo di esercizio o come una spesa da capitalizzare, portandone il relativo ammontare fra il valore della produzione – nel conto economico – e fra le immobilizzazioni immateriali – nello stato patrimoniale?
Questo è un caso tipico nel quale esigenze diverse entrano in conflitto e rendono la decisione particolarmente difficile. Da un lato c’è l’esigenza di rendere trasparente ciò che l’impresa sta facendo, distinguendo l’attività corrente da quella di investimento: ciò dovrebbe indurre a esporre come capitalizzazioni tutte le spese cui si contrappongono ricavi futuri. Dall’altro c’è il dato di fatto che i costi sono certi, mentre i ricavi futuri sono sperati: il che richiede una grande disciplina nel valutare se sono da considerarsi plausibili o semplicemente speranze senza fondamento. Ove si capitalizzino costi per investimenti mal fatti che mai daranno ricavi, si gonfiano gli utili di un esercizio e si falsa il significato del bilancio. Nella decisione se capitalizzare o non capitalizzare entra anche la questione fiscale: poiché queste poste non sono di facile valutazione, specialmente per degli esterni, si apre un’opportunità per un’impresa che non abbia bisogno di ampliare gli utili dichiarati: quella di spesare tutta o una parte dei costi relativi a progetti pluriennali risparmiando imposte e al tempo stesso assumere un comportamento prudenziale. Va da sé che in questo caso non tutto il valore creato dall’impresa emerge dai dati contabili, e quindi si viene meno al principio di trasparenza. Queste diverse esigenze pongono il management di fronte a una scelta di grande responsabilità: come trovare l’equilibrio fra l’esigenza di rappresentare correttamente i fatti aziendali, senza “abbellirli”, ma anche senza “svalutarli”, e quella di cogliere le opportunità di ottimizzazione che l’impianto normativo e fiscale consente. Si tratta di un esercizio di business judgement che le norme possono favorire, ma che rimane nelle responsabilità professionali del management e degli organi di governo dell’impresa.
In un’epoca nella quale le imprese non sono quasi mai una sola società, ma un gruppo composto di più unità, per la corretta rappresentazione della realtà aziendale assumono grande rilievo la questione della valutazione delle partecipate e quella del bilancio consolidato. Anche per quanto riguarda le partecipate – quelle che non vengono consolidate – si tratta di un esercizio delicato di business judgement: cosa che troppo spesso i nostri magistrati faticano ad accogliere. Anche qui si può peccare di ottimismo e continuare a riportare un valore, anche in presenza di perdite, perché non si considerano come durature, oppure si può procedere con svalutazioni energiche e disinvolte, anche al fine di cogliere il risparmio fiscale. In entrambi i casi non si realizza una corretta rappresentazione di bilancio: ma deve essere chiaro che – ferme e osservate le norme – si tratta di un difficile problema di valutazione in cui devono convergere senso di responsabilità e capacità professionali. Il primo per tenere conto dello spirito delle norme e, più in generale, dell’esigenza di trasparenza sui fatti aziendali, che risponde a un bisogno generale per il buon funzionamento dei mercati finanziari; le seconde per valutare le condizioni presenti e prospettiche dalle quali discendono le valutazioni. Sulla necessità che le regole di consolidamento consentano una chiara lettura della realtà aziendale non ci dovrebbero essere molti dubbi: il caso Enron è emblematico di una falla nella normativa americana e di un uso truffaldino di detta falla per escludere dal consolidamento realtà che di fatto erano controllate da Enron. Questa esclusione è servita a contabilizzare a favore dei bilanci Enron ricavi e plusvalenze fittizie per transazioni intercorse fra la medesima e le società escluse dal consolidamento e per dislocare su queste quote rilevanti di debito che erano di pertinenza reale della Enron. Queste operazioni hanno consentito di gonfiare gli utili e di ridurre l’esposizione finanziaria netta della società, sviando le valutazioni perfino degli organismi professionalmente dediti a tale funzione: gli analisti, le società di rating, gli investitoti istituzionali.
La lezione per il management, in questo caso, sembra cristallina: giocare con questi artifizi può pagare nel breve, ma alla fine si innesta una spirale letale che va ben al di là del punto al quale si dovrebbe fermare. Preoccupa che in Italia, sulla questione del consolidamento, come sul falso in bilancio, ci si muova in senso opposto rispetto a quello che l’esperienza Enron suggerisce. In un caso – si argomenta – per rimediare alle anomalie del sistema a scatole cinesi che condiziona il nostro sistema economico; nell’altro come reazione a interpretazioni aggressive della magistratura che non tenevano conto della natura eminentemente estimativa – e quindi delle possibilità di errore, non necessariamente di intento truffaldino – di certe poste di bilancio. In entrambi i casi si sottovaluta però l’altra faccia della medaglia: il valore “istituzionale” della veridicità dei bilanci, in quanto bene comune per il buon funzionamento di un’infrastruttura fondamentale dei sistemi capitalistici, quella dei mercati finanziari. Proprio perché la corretta rappresentazione della realtà aziendale è diventata oggettivamente più difficile (le prove potrebbero seguire a iosa), il management ha il dovere professionale anzitutto di dedicare a tali questioni più attenzione, non limitandosi a delegarle alla funzione amministrativa, e poi quello di acquisire le competenze tecniche e manageriali necessarie per affrontare i difficili problemi estimativi di cui si è dato un piccolo esempio. Ma per affrontare bene la questione è necessario che il management abbia forte anche il senso del futuro e non appiattisca le proprie scelte sul breve: se l’orizzonte temporale di riferimento è a più lunga durata, è più facile rifiutare scelte che premiano nel breve ma gettano i semi di problemi futuri.
Un problema di etica comportamentale
Non c’è dubbio che nel caso Enron siano emersi gravi problemi di etica da parte del management. Come è stato chiarito nel punto precedente, in parte la possibilità di tali comportamenti scaturisce dalla discrezionalità oggettiva che si è aperta nella formazione dei bilanci per i cambiamenti intervenuti nella natura delle attività economiche. Questa constatazione indica un dilemma tipico dell’economia di questi tempi: quanto più si aprono spazi sui quali occorre esprimere valutazioni i cui effetti possono essere gravi per l’impresa e per il sistema, ci sono solo due sistemi di correzione: o un ricorso a norme stringenti, il che va contro le necessità di deburocratizzare e snellire l’esercizio dell’attività economica per rispondere alla crescente pressione competitiva; oppure si fa conto su un sistema di autoregolazione che è poi l’essenza più concreta dell’etica professionale. Nel caso Enron sono state violate le più elementari regole di questo codice comportamentale, non scritto ma essenziale per la legittimazione del ruolo dirigenziale: inviando messaggi contabili fuorvianti che facevano impennare i corsi delle azioni, vendendo al contempo le proprie; il conflitto di interessi, con dirigenti diventati azionisti di imprese controparte, con transazioni in danno alla società; un’attività intensa e onerosa di lobby per orientare la formazione della politica industriale e forse anche specifiche transazioni. Agli atti della magistratura americana esiste una lettera non firmata inviata da Sherron S. Watkins, vicepresidente per lo sviluppo della Enron al suo presidente, Kenneth L. Lay, all’indomani delle dimissioni dell’amministratore delegato Jeffry K. Skilling, il 14 agosto 2001, che è una testimonianza impressionante della disinvoltura con la quale il management della Enron ha trattato le questioni etiche suddette.
Se non si vuole che la legge divenga stringente e penetrante su temi che per loro natura comportano più business judgement che mera applicazione di regole meccaniche, è necessario che il management si cimenti con più energia sul tema dell’autoregolamentazione. Il legislatore interverrà in modo tanto più incisivo e coercitivo quanto più frequenti e più gravi saranno i casi di comportamenti in danno di terzi e del mercato. Tocca al management che crede in un sistema flessibile, autoregolamentato, adattivo, creare le condizioni affinché esso volga in questa direzione. Questo a livello individuale, ma soprattutto a livello collettivo attraverso gli organismi professionali e di rappresentanza degli interessi: Assonime, borsa, associazione dei dirigenti. L’etica, in questa interpretazione restrittiva ma concreta, non è un afflato moralistico, ma è funzionale alla conciliazione degli interessi privati con quelli generali attraverso l’autoregolazione, anziché i processi legislativi e regolamentari.
Un problema di management in senso stretto
Come accennato in apertura, il caso Enron aveva destato l’attenzione degli studiosi per peculiarità del modello: un’impresa che si alleggerisce il più possibile di attività fisiche, cedendo impianti e pipelines, dando in outsourcing intere funzioni, per concentrare la propria attività nel coordinamento e nell’integrazione con meccanismi di mercato di una molteplicità di produttori indipendenti. Il prototipo dell’impresa rete, se non dell’impresa virtuale. In realtà, ci sono anche altri tratti della gestione Enron che sono stati meno osservati, ma che vanno a completare il suo modello di impresa: quello di un gioco aggressivo sul mercato dei capitali, quello del leverage e quello di una strategia intensa di acquisizioni su scala planetaria.
Quali lezioni possiamo trarre dalla rapida ascesa e dall’ancora più rapido crollo della Enron? Che anche tali strategie erano sbagliate, oppure che la crisi è imputabile esclusivamente a cattiva gestione sui punti prima illustrati? Per rispondere a tali quesiti possiamo ragionare su due livelli:
1. la trasformazione da impresa di produzione in impresa rete;
2. l’uso strumentale del mercato azionario per trascinare la strategia di sviluppo accelerato.
Sul primo punto è difficile giudicare, da quanto è accaduto, se il modello di impresa leggera, fortemente focalizzata sulle core competences, e fortemente dipendente dall’esterno fosse valido o meno. Le conoscenze a nostra disposizione indicano che, quando i mercati si liberalizzano e diventano fortemente competitivi, una parte delle attività che le imprese realizzano al loro interno devono essere dislocate sul mercato per acquisire concentrazione sui punti forti e flessibilità nel reperimento dei complementi. Quindi, la direzione di marcia era giusta, anche se non abbiamo elementi per valutare se sia stato dismesso più di quanto fosse necessario. Ma, a dispetto della giustezza della direzione di marcia, il caso Enron testimonia un errore che in simili processi di trasformazione si può compiere: quello di mutare profondamente la natura dell’impresa e di non rendersi conto che la nuova realtà è soggetta a fattori critici di successo diversi da quelli di partenza. Nel caso specifico, Enron si è trasformata nel tempo da impresa di immagazzinamento e distribuzione di gas in trader di commodities: gas, energia, acqua e altro. Un trader vive in funzione della propria capacità di stipulare contratti con fornitori per soddisfare le domande del mercato. Per un operatore siffatto la fiducia è non solo un fattore critico di successo, ma una conditio sine qua non: se viene a mancare, anche un grande impero cade nel giro di poco. Questo spiega il crollo straordinariamente rapido di quella che per capitalizzazione era la quarta impresa americana e una delle più grandi del mondo.
L’identificazione della fiducia come perno imprescindibile per l’operatività di un trader è ben nota alla comunità finanziaria che, nel tempo, ha dovuto prenderne atto e adeguare la gestione: si pensi alle corse agli sportelli che costituivano la spada di Damocle sul capo delle banche prima che queste adottassero gestioni conformi al pericolo e prima che le autorità predisponessero cinture di sicurezza per arginarlo.
A giudicare ex post, Enron non aveva avvertito quanto la trasformazione intrapresa l’avesse traghettata verso una nuova specie di impresa nella quale la fiducia giocava un ruolo così decisivo: diciamo che non l’aveva avvertito perché i giochi di bilancio, l’uso forte della leva finanziaria, le azioni ripetute per gonfiare i risultati sono quanto di peggio si possa attuare per minare la fiducia delle controparti. Quello di passare da un tavolo di gioco a un altro senza rendersi conto che le regole sono diverse è uno dei rischi che si corrono quando si procede a una rapida trasformazione di un’impresa. Altrettanto criticabile appare l’uso strumentale del mercato azionario per trascinare una strategia di sviluppo accelerato, errore che negli ultimi anni hanno commesso anche altre imprese, spesso sotto la spinta di una male interpretata teoria della massimizzazione del valore degli azionisti. Cosa si intende per “uso strumentale del mercato azionario”? Si intende quella prassi di gestione che, anziché dipanare la gestione partendo dal mercato di sbocco, dal prodotto, dai processi di approvvigionamento e dai processi di trasformazione, per poi interrogarsi su come rendere il tutto compatibile con le esigenze del mercato dei capitali, inverte il processo. Errore, questo, che si è diffuso negli ultimi anni. Esso si traduce nella messa in atto di interventi che, a prescindere dagli effetti che avranno sulla competitività duratura dell’impresa, comportano risultati che allettano il mercato azionario. Questi risultati e i relativi effetti sul valore delle azioni possono essere ulteriormente ampliati con giochi contabili sugli spazi di discrezionalità visti in precedenza, e possono essere “massaggiati” da un’intensa e strumentale attività di investor relations. In sintesi, una gestione industriale piegata alle esigenze di stimolare il titolo e altre attività, tutte indirizzate a questo scopo. L’obiettivo – a quel punto – diventa l’innalzamento del valore delle azioni, funzionale sia a raccogliere nuovi capitali sul mercato con nuove emissioni, sia ad avere a disposizione una acquisition currency rivalutata che consente di fare acquisizioni anche ad alto prezzo con l’emissione di azioni, riducendo la diluizione per gli azionisti.
In questo modello di gestione, acclamato da più di una società di consulenza, è insito un rischio che nel caso Enron è diventato palese a mano a mano che la strategia di acquisizioni procedeva: fare acquisizioni con disinvoltura, pagandole care. Prima o poi si incappa in qualche incidente che costringe a mettere nei conti minusvalenze capaci, se di ammontare significativo, di fare cambiare umore al mercato azionario. Se ciò accade, la spirale positiva indotta dai primi passi si inverte bruscamente e mette in cruda evidenza la qualità delle scelte gestionali, quelle vere, quelle che determinano la vera capacità competitiva dell’impresa.
Includere le aspettative del mercato azionario è non solo corretto, ma doveroso. Ma invertire i fattori è fonte di rischi: le imprese hanno successo duraturo solo se vincono la battaglia sul mercato del prodotto.
Conclusione
Il caso Enron, che tanto era stato studiato nelle aule delle business school americane quand’era nell’onda del successo, merita di essere studiato ancora di più dopo il crollo. Esso indica alcuni problemi di ordine generale che devono conquistare l’attenzione delle autorità e del legislatore. Ma è anche un esempio di grande interesse per comprendere cosa c’era di buono nella sua strategia – da non buttare sull’onda dello sconcerto per il fallimento improvviso – e quali aree di criticità sono emerse, quasi per essere d’esempio per il management di errori da non ripetere.
Tratto da:
https://emplus.egeaonline.it/it/61/archivio-rivista/rivista/3333731/articolo/3333735


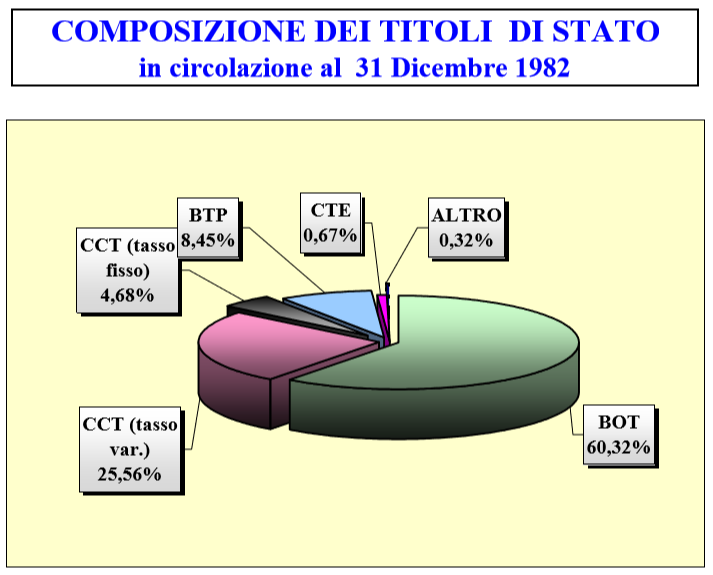


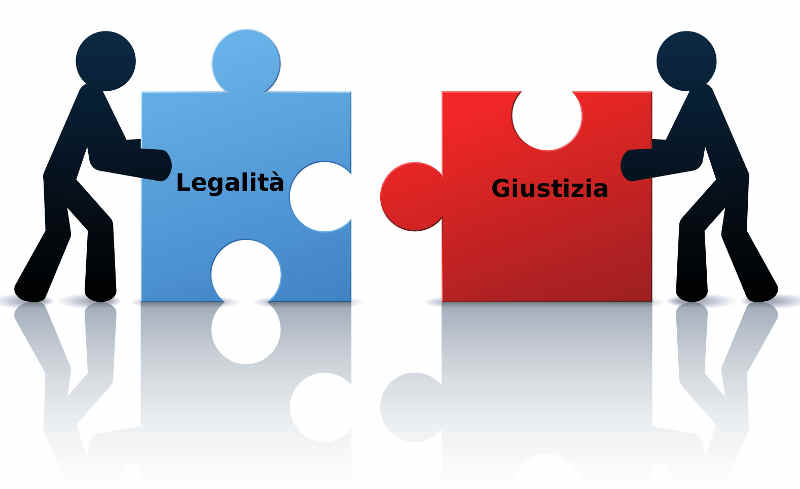
Lascia un commento