
di Massimo Bordin
rtuna, nonostante le devianze del dibattito contemporaneo, i documentari filmati, i libri e gli articoli scritti in epoca pre-covid rimangono, e nessuno può più toglierli dalla circolazione.
Spiegando le dinamiche della peste del Trecento in una classe di liceo, mi sono imbattuto in un vecchio articolo di Alessandro Barbero, pubblicato sul libro di storia in dotazione tra i testi consigliati per la miglior comprensione del fenomeno. Merita che ne pubblichi qui un estratto, dato che il più famoso e celebrato storico italiano viene tirato in ballo solo quando fa comodo a qualcuno, ma viene in buona sostanza ignorato quando si parla della pandemia in corso.
Le frasi in grassetto sono mie.
di Alessandro Barbero (estrapolato dal Sole 24Ore – 28 dicembre 2008)
Sul piano congiunturale, il Trecento ne ha viste abbastanza da farci rallegrare di non esserci nati: è allora che si stabilizza la formula dell’Apocalisse, “peste fame guerra”, da cui per secoli gli europei pregheranno d’essere liberati. Prima, la peste era soltanto una malattia di cui si parlava nei libri, nella Bibbia o nei romanzi su Troia, e per immaginare che potesse tornare ad ammucchiare i cadaveri nelle strade di un mondo fervido di iniziative e traboccante di ottimismo com’era quello medioevale ci voleva la fantasia di un moralista visionario: come quell’anonimo pittore che affrescò il “Trionfo della Morte” nel Camposanto di Pisa, ben prima che la peste facesse la sua apparizione in Europa. Ma quando venne davvero, nel 1348, offrendo fra l’altro al Boccaccio la cornice per il Decameron, aprì tali vuoti nei quartieri sovraffollati delle città industriali da alimentare l’idea, certamente esagerata, che metà della popolazione soccombesse in pochi mesi.
Perfino uno shock di quelle dimensioni, tuttavia, poteva essere riassorbito da un’Europa giovane e vitale, la cui struttura demografica era simile a quella odierna del Terzo mondo: ma da allora la peste si ripresentò implacabilmente ogni dodici o quindici anni, impedendo ogni ripresa, sicché all’inizio del Quattrocento gli esattori delle tasse (è grazie ai loro registri che conosciamo questi dati!) trovavano ovunque che il numero dei contribuenti si era dimezzato rispetto ai tempi d’oro.
Ma il Trecento è anche un secolo di guerre crudeli e logoranti, per una combinazione micidiale di fattori. Esistono ormai Stati organizzati, capaci di perseguire una politica di espansione e di conquista, come l’Inghilterra, che per oltre un secolo continuò ostinatamente a illudersi di poter conquistare la Francia, o quello Stato Visconteo che da Milano sembrava avviato a unificare l’Italia sotto il segno della tirannide. Questi Stati sono capaci di rastrellare denaro, fra le lamentele dei contribuenti vessati, e di investirlo nella guerra; ma rispetto agli obiettivi il denaro è sempre troppo poco, in un’economia cresciuta troppo in fretta e che soffre d’una cronica carenza di liquido. Perciò gli eserciti sono piccoli e operano su scala locale, i mercenari in attesa degli arretrati badano più a saccheggiare le campagne che a combattere i nemici, e le guerre si trascinano senza fine, al punto che quella tra Francia e Inghilterra è passata alla storia come la Guerra dei Cent’anni.
Oggi i politologi parlerebbero di “conflitti a bassa intensità”: e tutti possiamo immaginare
quanto sia fuorviante questa definizione, se vista con gli occhi dei contadini ai quali gli uomini d’arme bruciavano le case, portavano via il bestiame e stupravano le figlie, o dei mercanti che non potevano mettersi in cammino per le varie fiere senza il rischio di essere bloccati sulle strade maestre da gente armata e nel migliore dei casi ritrovarsi in braghe.
Se si aggiunge che la massima autorità morale dell’Occidente cristiano, il Papato, offriva ai buoni cristiani lo spettacolo poco edificante di due pontefici rivali intenti a scomunicarsi a vicenda, e che a quest’epoca divampano le più feroci rivolte contadine e operaie che l’Occidente abbia conosciuto prima delle moderne rivoluzioni, non è difficile capire come mai per molto tempo gli storici abbiano parlato senza esitazioni e senza virgolette della crisi del Trecento. Eppure, da un po’ di tempo capita sempre più spesso di trovarle, quelle virgolette, attorno alla parola “crisi”, anche grazie ai nuovi materiali che continuano ad emergere dagli archivi (e già questo è un fatto che dà da pensare: quell’Europa in fiamme, dove però intanto era stata inventata la carta, ci ha lasciato una massa di documenti scritti enormemente superiore a tutto quello che era stato prodotto prima).
Si finisce così per fare una considerazione cinica, forse, ma inoppugnabile: a ogni ritorno della peste, tanto peggio per chi ci lascia la pelle, ma i vivi stanno meglio di prima. C’è chi ha ereditato dallo zio o dal cugino, chi ha visto sparire l’azienda concorrente, chi si ritrova libero di sposarsi e fare nuovi figli. Gli operai in città e i braccianti in campagna scoprono d’essere rimasti in pochi, e se il padrone non aumenta il salario si può sempre trovarne un altro che ha un gran bisogno di manodopera ed è disposto a pagare di più. I padroni protestano contro questi soprusi, esigono a gran voce leggi che fissino un tetto ai salari, ma intanto pagano, e la povera gente ha più soldi in tasca di quanti ne abbia mai avuti. Li usa per vestirsi meglio e per mangiare meglio: il consumo di vino e di carne è a livelli che non saranno superati prima dell’Ottocento, non ci sono mai state tante botteghe di macellaio, e quegli imprenditori che anziché velluti per i ricchi, come si ostinano a fare a Firenze, imparano a produrre solidi fustagni a buon mercato per la gente che lavora, scoprono che la crisi è anche un grandissimo affare …



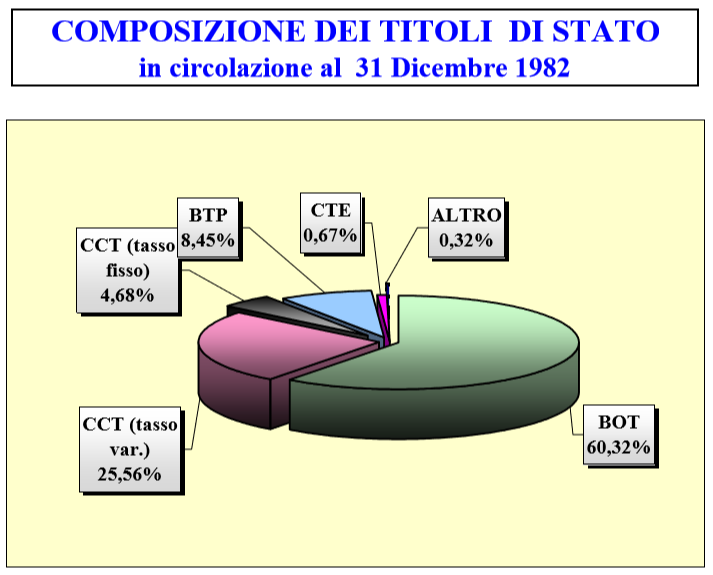



Lascia un commento